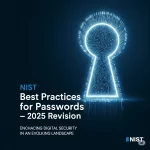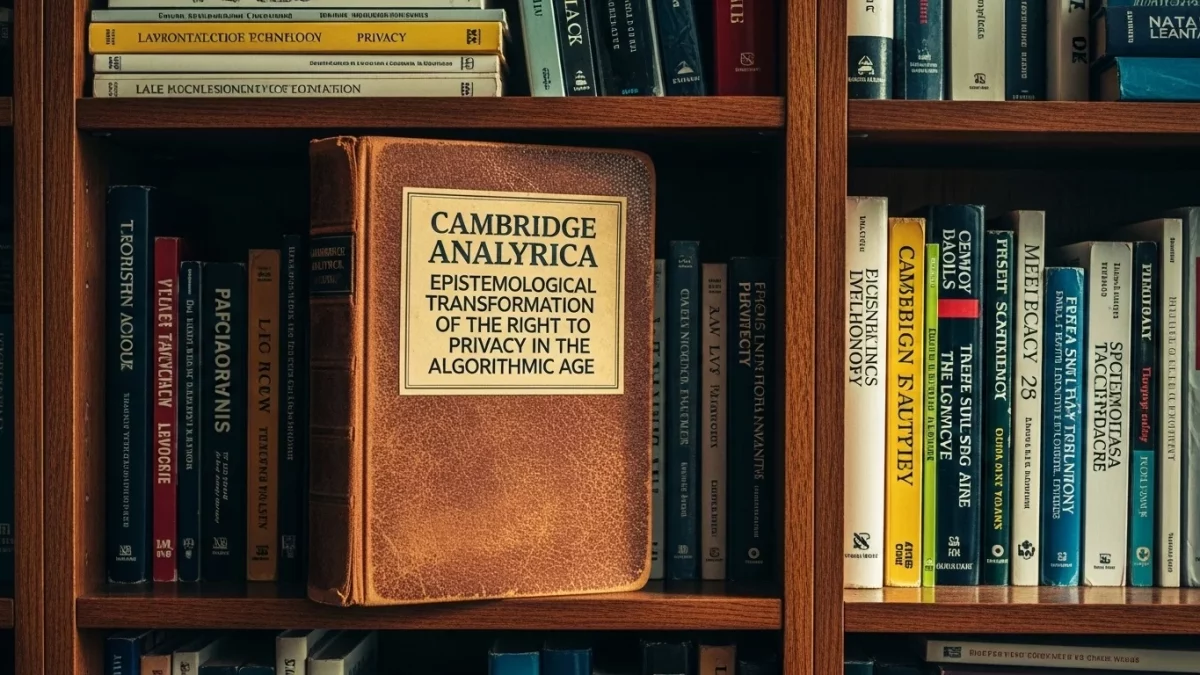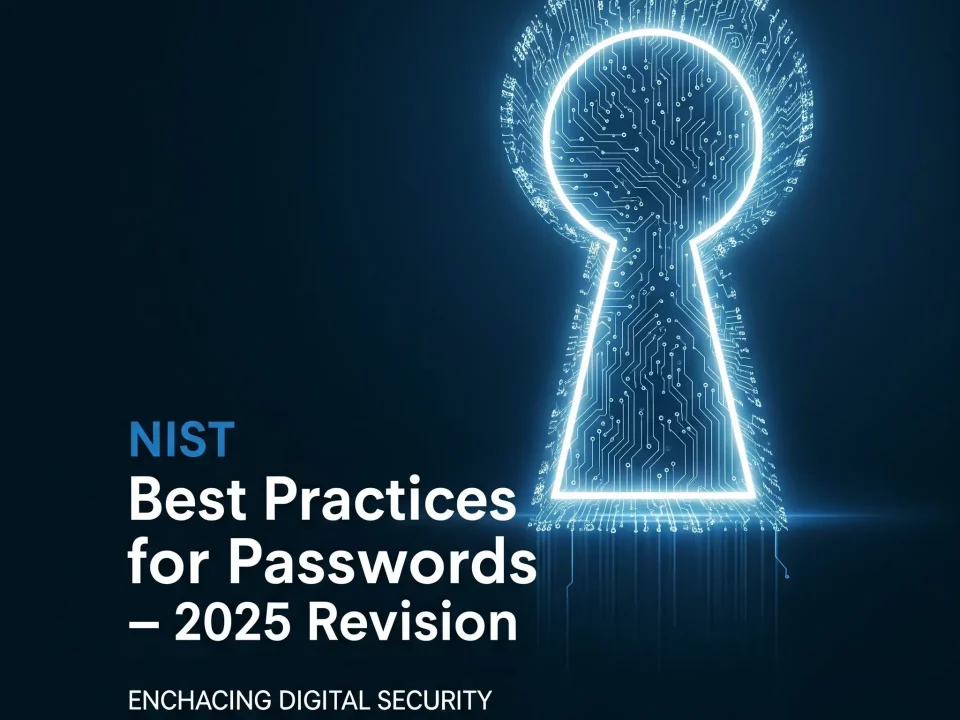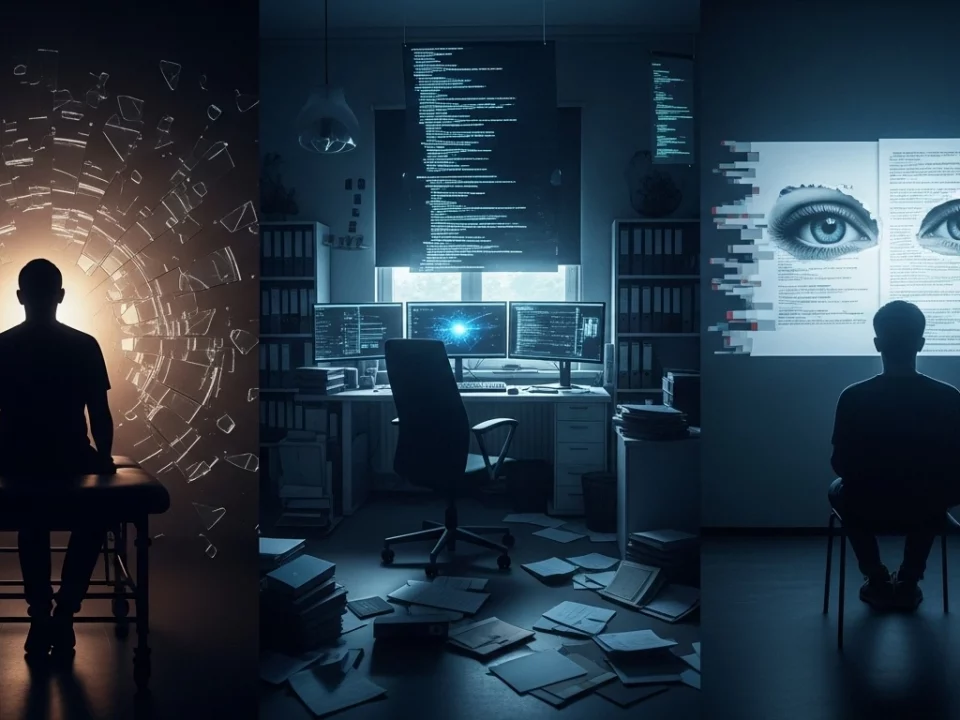Abstract
Il presente studio esamina il caso Cambridge Analytica come paradigma della trasformazione epistemologica che ha investito il diritto alla privacy nell’era digitale, integrando prospettive multidisciplinari derivanti dall’analisi etica, psicologica e tecnologica della manipolazione algoritmica. L’analisi sistematica delle dinamiche di data politics e delle loro implicazioni giuridiche delinea un quadro critico delle insufficienze normative attuali, evidenziando come le pratiche di micro-targeting comportamentale e modulazione emotiva abbiano costituito un caso emblematico del “black boxing” dei processi decisionali democratici.
La ricerca si struttura attraverso un approccio metodologico che integra l’analisi giuridico-normativa con lo studio delle risposte dei consumatori e delle implicazioni per la soggettività digitale. Particolare attenzione è dedicata al concetto di “care” nel trattamento dei dati personali, evidenziando come la violazione dei doveri di cura da parte delle diverse entità coinvolte (Facebook, Cambridge Analytica, Aleksandr Kogan) abbia determinato una compromissione sistemica dei diritti fondamentali degli interessati.
Il lavoro si articola in tre nuclei fondamentali: l’analisi della ridefinizione concettuale della privacy da diritto soggettivo a oggetto di modulazione algoritmica; l’esame delle modalità attraverso cui la correlazione statistica ha sostituito la causalità come paradigma conoscitivo; l’individuazione delle lacune dell’attuale quadro normativo europeo nella protezione dai danni algoritmici. L’indagine evidenzia inoltre come gli attuali approcci tecnici alla privacy nel machine learning risultino inadeguati rispetto alle dinamiche di manipolazione psicologica e subliminale vietate dall’AI Act dell’Unione Europea.
La dimensione etica emerge come elemento centrale nell’analisi, con particolare riferimento alle linee guida etiche per l’intelligenza artificiale elaborate dal gruppo di alto livello della Commissione europea, che enfatizzano l’approccio “human-centric” e i principi di beneficio umano, non danno e autonomia. La ricerca propone una riforma normativa orientata alla tutela della soggettività digitale che tenga conto delle trasformazioni in atto nei processi decisionali automatizzati e della necessità di garantire trasparenza algoritmica e responsabilità nelle pratiche di profilazione comportamentale.
Introduzione: Il paradigma Cambridge Analytica e la crisi del diritto alla privacy
Inquadramento problematico
Lo scandalo Cambridge Analytica, emerso nella sua drammatica evidenza nel 2018, costituisce un caso paradigmatico della trasformazione radicale che ha investito il concetto giuridico di privacy nell’era dell’intelligenza artificiale e dei big data. La vicenda non rappresenta meramente una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, ma evidenzia una mutazione epistemologica profonda che ha investito i fondamenti stessi del diritto alla riservatezza.
Il caso rivela come la privacy sia stata progressivamente ridotta da diritto fondamentale della personalità a parametro tecnico-matematico, oggetto di manipolazione attraverso algoritmi di profilazione psicografica. Questa trasformazione impone una riflessione sistematica sulle categorie giuridiche tradizionali e sulla loro capacità di tutelare la soggettività digitale nell’era algoritmica.
Metodologia d’analisi
L’approccio metodologico adottato integra l’analisi giuridico-sistematica con la prospettiva genealogica, al fine di delineare le dinamiche di potere che sottendono la trasformazione del diritto alla privacy. L’analisi si struttura su tre livelli:
Inquadramento normativo: La disciplina europea della protezione dei dati
Il quadro normativo di riferimento
Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) costituisce il riferimento normativo fondamentale per l’analisi del caso Cambridge Analytica. L’articolo 1, paragrafo 1, del GDPR stabilisce che il regolamento “stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”.
La definizione di “dato personale” contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, del GDPR – “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” – assume particolare rilevanza nell’analisi del caso, poiché include esplicitamente “un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
La profilazione e il trattamento automatizzato
L’articolo 4, paragrafo 4, del GDPR definisce la profilazione come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.
La normativa prevede specifiche tutele per i processi decisionali automatizzati, stabilendo all’articolo 22 che “l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”.
Le lacune dell’attuale quadro normativo
L’analisi del caso Cambridge Analytica evidenzia significative lacune nell’attuale quadro normativo europeo:
a) Insufficienza del meccanismo del consenso: Il GDPR prevede il consenso come una delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali, richiedendo che sia “libero, specifico, informato e inequivocabile” (articolo 4, paragrafo 11). Tuttavia, la prassi del “pay or okay” adottata da molte piattaforme digitali compromette la genuinità del consenso, rendendo di fatto illusoria la libertà di scelta dell’interessato.
b) Limitata efficacia della tutela contro la profilazione: Nonostante le previsioni dell’articolo 22, la tutela contro i processi decisionali automatizzati risulta inefficace rispetto alle tecniche di micro-targeting comportamentale, che operano attraverso meccanismi di modulazione emotiva piuttosto che attraverso decisioni algoritmiche dirette.
c) Inadeguatezza del concetto di “dato personale”: La definizione normativa non coglie pienamente le dinamiche di inferenza algoritmica che consentono di dedurre informazioni sensibili da dati apparentemente neutri, come dimostrato dal caso Cambridge Analytica dove i “like” di Facebook venivano utilizzati per costruire profili psicografici dettagliati.
La trasformazione epistemologica: Dalla causalità alla correlazione
Il paradigma correlazionale
Il caso Cambridge Analytica esemplifica una trasformazione epistemologica fondamentale: il passaggio dalla causalità alla correlazione come modalità di produzione della conoscenza. Questa mutazione, che affonda le sue radici nella meccanica statistica e nella cibernetica, ha profonde implicazioni per il diritto alla privacy.
Nel paradigma tradizionale, la conoscenza si basava sulla comprensione delle relazioni causali tra fenomeni. Nel nuovo paradigma algoritmico, la “verità” viene prodotta attraverso l’identificazione di correlazioni statistiche tra variabili, prescindendo dalla comprensione delle dinamiche causali sottostanti.
La riduzione matematica della privacy
La trasformazione epistemologica ha comportato una riduzione matematica della privacy, che da diritto soggettivo fondamentale viene ricondotta a parametro tecnico misurabile attraverso soglie statistiche. Questo approccio si manifesta attraverso:
Implicazioni giuridiche della trasformazione epistemologica
La trasformazione epistemologica produce significative implicazioni per il diritto alla privacy:
a) Erosione del controllo individuale: La logica correlazionale prescinde dalla volontà e dalla consapevolezza dell’interessato, compromettendo il principio di autodeterminazione informativa.
b) Alterazione del rapporto soggetto-oggetto: L’individuo viene ridotto a aggregato di dati correlabili, perdendo la sua dimensione soggettiva e divenendo oggetto di manipolazione algoritmica.
c) Mutazione del concetto di danno: Il danno alla privacy non deriva più dalla divulgazione di informazioni riservate, ma dalla manipolazione comportamentale attraverso stimoli algoritmici personalizzati.
La data politics e la modulazione della soggettività digitale
Verso una nuova modalità di potere
Il caso Cambridge Analytica rivela l’emergere di una nuova modalità di potere, definibile come data politics, che si distingue dalle forme tradizionali di potere disciplinare e biopolitico teorizzate da Michel Foucault.
Mentre il potere disciplinare mira alla produzione di “corpi docili” attraverso la sorveglianza e la normalizzazione, e la biopolitica si concentra sulla gestione delle popolazioni attraverso tecniche statistiche, la data politics opera attraverso la modulazione automatizzata dei comportamenti individuali.
Caratteristiche della data politics
La data politics presenta caratteristiche peculiari:
a) Targeting delle emozioni
La modulazione non opera attraverso la razionalità ma attraverso la manipolazione emotiva, come dimostrato dalla strategia di Cambridge Analytica di alimentare paura e ansia negli elettori con elevati livelli di nevroticismo.
b) Personalizzazione algoritmica
Gli interventi sono altamente personalizzati, basati su profili psicografici individuali costruiti attraverso l’analisi delle tracce digitali.
c) Operatività nel contesto digitale
La modulazione avviene nell’ambiente digitale, senza coercizione fisica diretta, ma attraverso la progettazione dell’esperienza utente.
d) Adattamento in tempo reale
Gli algoritmi si automodificano continuamente sulla base dei feedback comportamentali, ottimizzando l’efficacia della modulazione.
La costruzione della soggettività dividuale
La data politics opera attraverso la costruzione di soggettività dividuali, ovvero profili digitali che rappresentano “aspetti dell’astrazione degli esseri umani da parte dei dati”. Queste dividualità non corrispondono all’identità reale dell’individuo ma costituiscono costruzioni algoritmiche finalizzate alla modulazione comportamentale.
Il processo di costruzione della soggettività dividuale si articola in fasi:
Analisi critica del caso Cambridge Analytica
Cronaca giuridica della vicenda
Il caso Cambridge Analytica si articola attraverso una complessa sequenza di violazioni normative che coinvolgono diversi soggetti e giurisdizioni.
a) Il meccanismo di raccolta dati
L’applicazione “This is Your Digital Life”, sviluppata da Aleksandr Kogan, sfruttava una vulnerabilità dell’API di Facebook per raccogliere dati non solo dagli utenti che installavano l’applicazione, ma anche dai loro “amici”, in violazione del principio di consenso informato.
b) La costruzione di profili psicografici
Cambridge Analytica utilizzava i dati raccolti per costruire profili psicografici basati sul modello “Big Five” (OCEAN), inferendo tratti di personalità attraverso correlazioni statistiche tra “like” di Facebook e caratteristiche psicologiche.
c) Il micro-targeting comportamentale
I profili psicografici venivano utilizzati per implementare strategie di micro-targeting comportamentale, esponendo gli utenti a contenuti personalizzati finalizzati alla manipolazione delle decisioni politiche.
Violazioni normative identificate
L’analisi giuridica del caso evidenzia molteplici violazioni normative:
a) Violazione del principio di trasparenza: Il trattamento dei dati avveniva senza adeguata informativa agli interessati, in violazione dell’articolo 13 del GDPR.
b) Assenza di base giuridica: Il trattamento dei dati degli “amici” degli utenti dell’applicazione mancava di una valida base giuridica, non essendo basato su consenso né su altro fondamento legittimo.
c) Violazione del principio di limitazione della finalità: I dati raccolti per scopi apparentemente accademici venivano utilizzati per finalità commerciali e politiche, in violazione del principio di limitazione della finalità.
d) Inadeguatezza delle misure di sicurezza: La cessione dei dati a terzi senza adeguate garanzie contrattuali violava gli obblighi di sicurezza nel trattamento.
L’insufficienza della risposta normativa
La risposta normativa al caso Cambridge Analytica si è rivelata inadeguata rispetto alla gravità delle violazioni:
a) Limitatezza delle sanzioni: Le sanzioni irrogate sono risultate sproporzionate rispetto ai profitti generati e all’entità del danno causato.
b) Mancanza di deterrenza: L’assenza di misure strutturali ha consentito la persistenza di pratiche analoghe in altri contesti.
c) Focalizzazione sulla compliance formale: L’attenzione si è concentrata sulla conformità formale alle norme piuttosto che sulla prevenzione del danno sostanziale.
Implicazioni sistematiche per il diritto alla privacy
La crisi del paradigma tradizionale
Il caso Cambridge Analytica evidenzia una crisi strutturale del paradigma tradizionale del diritto alla privacy, fondato sui principi di:
La necessità di nuovi paradigmi giuridici
L’analisi del caso suggerisce la necessità di sviluppare nuovi paradigmi giuridici orientati alla tutela della soggettività digitale:
Proposte di riforma normativa
Sulla base dell’analisi condotta, si propongono le seguenti direzioni di riforma:
a) Rafforzamento del controllo algoritmico: Implementazione di meccanismi di controllo ex ante sui sistemi algortmici utilizzati per la profilazione comportamentale.
b) Introduzione del diritto alla spiegazione algoritmica: Riconoscimento del diritto dell’interessato a ottenere spiegazioni comprensibili sui processi algoritmici che lo riguardano.
c) Regolamentazione della modulazione comportamentale: Introduzione di divieti specifici per le pratiche di modulazione comportamentale basate su vulnerabilità psicologiche.
d) Responsabilità algoritmica: Attribuzione di responsabilità civile e penale per i danni causati da sistemi algoritmici discriminatori o manipolatori.
Conclusioni
La portata paradigmatica del caso
Il caso Cambridge Analytica rappresenta un momento di svolta nella comprensione giuridica della privacy nell’era digitale. La vicenda non costituisce meramente una violazione delle norme esistenti, ma rivela l’emergere di nuove modalità di potere che operano attraverso la manipolazione algoritmica della soggettività.
L’urgenza di una riforma sistemica
L’analisi condotta evidenzia l’urgenza di una riforma sistemica del diritto alla privacy che tenga conto delle trasformazioni epistemologiche in atto. Il diritto non può limitarsi a regolamentare il trattamento dei dati, ma deve affrontare le dinamiche di potere che sottendono la costruzione algoritmica della soggettività.
Prospettive di ricerca
Il presente studio apre diverse prospettive di ricerca:
Considerazioni finali e prospettive
Il caso Cambridge Analytica ci insegna che la privacy non è più questione di segretezza, ma di potere. La sfida per il diritto contemporaneo è quella di sviluppare strumenti giuridici adeguati a tutelare la dignità umana nell’era algoritmica, garantendo che la tecnologia rimanga al servizio dell’uomo e non diventi strumento di sua manipolazione.
La protezione della soggettività digitale richiede un approccio olistico che integri tutele tecniche, garanzie procedurali e principi sostanziali orientati alla preservazione dell’autonomia individuale. Solo attraverso questo sforzo coordinato sarà possibile costruire un ordine giuridico digitale che rispetti la dignità della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale.
Dott. Luca Morini | DPO e Consulente Legale-Tecnico AI
Bibliografia
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
Fonti dottrinali
- Balkin, J.M. (2018). “Information Fiduciaries and the First Amendment”, UC Davis Law Review, 49(4), 1183-1234.
- Cohen, J.E. (2012). “What Privacy is For”, Harvard Law Review, 126(7), 1904-1933.
- Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Solove, D.J. (2002). “Privacy and Power: Computer Databases and Metaphors for Information Privacy”, Stanford Law Review, 53(6), 1393-1462.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, New York: PublicAffairs.